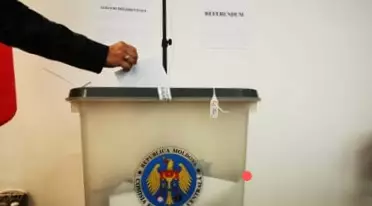Persepolis
Data: 10 Ottobre 2022
Tag: Racconti
Di: Elena Mora

Dicembre 1795
Shiras, Persia
Il tedesco non era ancora guarito e nessuno lo vedeva da un pezzo. Si era
rinchiuso all’ombra della sua tenda, la gamba fasciata e il veleno dello scorpione
che cercava disperatamente di salire fino al cuore. Alcuni dicevano che forse si
vergognava tanto per un’eventuale amputazione che non sarebbe uscito più.
Si sentiva di tanto in tanto la sua voce cavernosa, con quell’accento così duro,
provenire dai meandri della tenda. Alcuni l’avevano perfino sentito delirare, durante
la notte, pronunciare parole senza senso. C’era chi s’era arrischiato a scostare un
poco la tenda e l’aveva visto inzuppato di sudore, a rotolarsi nel letto.
Passarono così quindici giorni, fra chiacchiere, pettegolezzi e preoccupazione, fino
a quando, di buon mattino, lo intravidi seduto sotto il sole nascente, ad ammirare il
fiume.
Lo raggiunsi coprendo una ventina di metri, poi mi sedetti con lui.
Il fiume formava larghe anse dall’acqua placida e scintillante, come se non avesse
avuto fretta. Scorreva da sempre e per sempre, s’era macchiato di rosso molte
volte, ma la corrente aveva portato via ogni traccia di storia passata.
Era sempre nuovo, vivo, incurante degli uomini. Il sole l’avrebbe continuato a
baciare fino alla fine del mondo. Ogni notte, si sarebbe tinto di nero, ma il fiume non
aveva paura.
Perché sapeva, sì. Sapeva che il sole sarebbe sorto ancora.
Il tedesco mi guardò di scorcio e mi fece un cenno con la mano. Io ricambiai e
l’occhio mi cadde sulla sua gamba. La benda era sparita nel nulla.
L’uomo prese la sacca che teneva a sinistra, vi frugò dentro con respiro irregolare e
si girò a fissarmi. Aveva l’aria di un bambino che nascondeva un segreto e che faceva di tutto per fartelo capire. Aprì la sacca con un sussulto e mi mise in mano
quella che pareva una mattonella. Un tempo doveva essere stata sommersa dallo
stucco, pensai.
La guardai con attenzione ed intravidi in cima una graziosa incisione, una sorta di
fregio.
“Ha capito?”.
“Cosa?”.
“Non è una decorazione qualunque. Sono parole, parole antichissime.”
Posai con delicatezza la tavoletta nella sacca. Le mie mani rimasero sporche di
una terra primordiale e misteriosa.
“Che fine ha fatto la benda?”.
Lui sorrise. Poi guardò il fiume. “Mi serviva un po’ di tempo per me. È un
ritrovamento così affascinante.”
“Non sono parole, signore.”
“Lo vede questo fiume?”. Sulla superficie iridata si era posato un uccello dal becco
appuntito. Immerse la testa nell’acqua, sbatté le ali un paio di volte, per poi tuffarsi
nella corrente. Lo vedemmo risalire verticalmente pochi secondi dopo, infrangere
l’acqua e l’aria e volare alto fino al cielo.
“Lo vedo.”
“Lei non capisce la lingua del fiume, né ci riesco io. Ma ha mille storie da
raccontare, e le parole per farlo.”
Lo lasciai da solo, a cullarsi davanti all’acqua dolce, mentre mi avviavo a passi
svelti verso il sito. Mi voltai dopo alcuni secondi, ma lui non c’era più.
Forse non c’era mai stato. Forse era stata soltanto un’illusione.
Dev’essere abbastanza comune abbandonarsi al sogno, laggiù, in Mesopotamia.
Febbraio 1802
Göttingen, Germania
Una notte buia e tempestosa
Avevo così tanto sonno che ormai non sarei più riuscito a dormire.
Avevo dimenticato come chiudere gli occhi, così li tenevo spalancati, fissi sul tavolo
di legno scuro. Circondato dalle grida e dalle urla di ragazzi, professori, universitari
di vario genere e semplici intrusi che, se stavano cercando un senso nella propria
vita, io non li avrei davvero potuti aiutare.
“Professore, come è nata la sua passione per l’antico Oriente?”. Me l’aveva chiesto
uno studente e io non avevo ancora trovato una risposta.
“L’Oriente è sempre stato antico, Johann. Quando nacque Cesare, era già vecchio
di millenni. Non è un’eredità facile da portare, sai?”.
Ecco. Ecco, sì, ti prego…gli occhi mi si stavano per chiudere…
Niente. Ero destinato a passare la notte in bianco. Alzai mestamente un dito e
chiesi al ragazzo un’altra coppa di birra.
Qualcuno aveva appena fatto una battuta. Risi meccanicamente, poi sollevai lo
sguardo per vedere chi era stato così acuto da suscitare così tanta ilarità. Ilarità.
Parola complessa per i pensieri di un uomo alle quattro del mattino.
La voce assomigliava a quella di Grotefend. Forse un po’ più rauca, più stanca del
solito, ma pur sempre allegra. Accanto a me, un individuo sconosciuto si stava
sganasciando dalle risate.
Diamine, pensai. E mi spostai di qualche centimetro da lui. Poi Grotefend si mutò,
perché era così che faceva. Seguiva i propri pensieri fino ad un certo punto, poi si
stancava e rimaneva zitto. In questo modo, nessuno si annoiava mai per quello che
diceva.
Non ce n’era pericolo, perché, se avesse detto qualcosa di noioso, avrebbe fermato
lo scroscio di parole prima ancora di finire il discorso.
Era un genio, quel ragazzo. Quanto aveva, ventisette, ventotto anni? Non lo
sapevo, pareva ancora un bambino nel viso. Negli occhi.
O forse era un pazzo. La maggior parte delle volte, è esattamente la stessa cosa.
I geni sono pazzi ed è dai pazzi che vengono fuori le idee più geniali.
Non che avesse combinato nulla, nella vita, sia chiaro. Era quel tipo di persona,
però, che avrebbe potuto fare qualcosa di buono per l’umanità. Un eroe, un
condottiero, uno scienziato, forse. Che poi non facesse nulla, beh, quello era un
altro discorso.
Rizzai le orecchie ad un certo punto. Mi era bastato sentir nominare quel nome,
Persepoli, perché tutto il mio sonno svanisse e recuperassi tutta la mia attenzione.
“Pazzi! Pazzi, completamente pazzi! Una scrittura, dico io…una scrittura! Ma li
hanno visti? Quelli sono soltanto dei fregi, strane incisioni senza senso. Era un
popolo barbaro, diamine, barbaro. E quelli sono soltanto segni. Come un bambino
piccolo che cerca di scrivere qualcosa ma non ci riesce. Linee, punti…oddio, non
diranno davvero sul serio?”. Plymouth si contorse in una strana risata simile ad un
singhiozzo. Nella notte buia del locale, il suo volto pallido da inglese si stagliava
luminoso come una candela.
Un ragazzo dal ciuffo rosso gli rispose con una pacca sulla spalla. Si misero a
ridere sguaiatamente, ma io non prestavo loro più la minima attenzione.
Barbari, li aveva definiti. Perché non era mai stato laggiù, sotto il sole cocente, fra
le rovine di un maestoso palazzo che migliaia di anni prima aveva dominato il
mondo.
Non aveva camminato in groppa ad un cammello nel deserto, per poi accamparsi in
mezzo al nulla nella inutile speranza di trovare qualche resto, qualche fregio d’oro
che non fosse soltanto un’illusione. Non era entrato nei villaggi di pastori vicini, non
aveva ammirato le donne persiane che danzavano sotto una luce soffusa, avvolte
da un fumo denso e violetto.
Non aveva mai vissuto nulla di tutto ciò, e dunque poteva parlare. Io, invece, non
potevo parlarne, se non attraverso date e reperti, perché anche solo dire la mia
opinione su un luogo così lontano e così magico sarebbe stato un sacrilegio.
Lui poteva parlarne perché non conosceva ciò di cui stava parlando. Io che
conoscevo, invece, mi accorgevo sempre di più che nessuno avrebbe mai
conosciuto tutto.
Plymouth mi rivolse uno sguardo con aria enfatica: “Ma sentiamo il parere
dell’esperto, eh? Che cosa ne dice, lei, è una scrittura, quella? Eh? Pensa davvero
che un popolo del genere potesse avere qualche forma di cultura?”.
“Se avesse visto i palazzi di Persepoli” esclamai, accigliato, “Credo che potrebbe
constatare con sicurezza che quelli una cultura l’avevano, e forse molto più
moderna della nostra.”
“Ah! Il professore si rifiuta di rispondere, eh? Inguaribile romantico, già. Che cosa
insegna ai suoi studenti, l’amore per un popolo vecchio e decrepito in mezzo alla
sabbia?”.
Non ribattei. Avrei potuto, già, ma non ne avevo la minima voglia. Era ubriaco
fradicio e sapevo già che l’indomani, prima di entrare nella sua classe di scienze, si
sarebbe scusato. Avrebbe indossato la sua cravatta migliore, si sarebbe pettinato
con cura e mi avrebbe rivolto le sue più sincere scuse, perché “ieri sera non ero in
me” e cose di questo tipo.
“Professore, se proprio crede che sia una scrittura, allora la decifri. Ci spieghi che
diavolo vogliono dire quelle linee, quei cunei stravaganti. Porti alla luce quella
meraviglia di cui parla a quei poveri studenti. Ha paura, professore? Ha paura?”.
Non avrei accettato la sfida anche solo per quest’ultima provocazione. Non avevo
paura, semplicemente, Plymouth aveva dimenticato che non avevo mai sostenuto
nulla a proposito di un’eventuale forma di scrittura mesopotamica. Mi ero astenuto,
limitandomi ad osservare con una certa dose di sacralità, quelle tavolette.
Lei non capisce la lingua del fiume, né ci riesco io. Ma ha mille storie da raccontare,
e le parole per farlo.
Mi tornò in mente quel momento, per poi sparire di nuovo, all’improvviso.
“Plymouth, stai zitto. Va’ a dormire, che è meglio.” Commentai, laconico.
Fu allora che Grotefend, dal profondo del suo silenzio, alzò una mano. Nessuno si
accorse di lui, ma a poco a poco i suoi colpi di tosse attirarono la nostra attenzione.
“Cos’hai, Grotefend?” domandò Plymouth, con sarcasmo.
“Accetto la sfida.”
“Che cosa?”.
“Ho detto che accetto la sfida. Datemi solo un po’ di tempo e vi prometto che
riuscirò a decifrare quei segni.”
Plymouth si mise a ridere, ma Grotefend continuò, imperterrito: “Se è una scrittura,
la riuscirò a decifrare. Ho solo bisogno di tempo.”
Tutti ci guardammo, straniti. Plymouth, dopo qualche minuto, esclamò: “D’accordo.
Facciamo una scommessa. Se ci riuscirai entro un anno, io me ne andrò da questa
università.” Ci fu un mormorio sommesso, che lui zittì con un cenno della mano.
“Ma se sarai tu a perdere, allora dovrai andartene per sempre. Intesi?”.
Quando si strinsero la mano, ebbi la conferma che Grotefend non era affatto un
genio.
Era semplicemente pazzo.
Marzo 1802
Göttingen, Germania
Mattina
Era una tiepida mattina di marzo e portavo il mio ombrello a svagarsi fuori,
nonostante non minacciasse pioggia. Quando mi sedetti accanto al grosso faggio,
sulla panchina spoglia e stanca, mi accorsi che qualcuno stava venendo verso di
me.
“Georg!” salutai con la mano, mentre Grotefend si avvicinava, a passo spedito.
Erano quindici giorni che non lo vedevo, da quella malaugurata sera. Si era chiuso
in camera e usciva soltanto per le lezioni. Non frequentava più nessuno da un po’,
come se avesse avuto un gran peso sul cuore.
“Grotefend, vecchio mio, vieni qui.” Lui obbedì e si sedette accanto a me.
“Ho un problema.” L’avevo immaginato.
“Devo decifrare la scrittura cuneiforme, giusto?”.
“Giusto”.
“Ecco, infatti. Il mio problema è questo: come posso riuscirci senza le tavole?”. Mi
battei una mano sulla testa. Pazzo, pazzo era! Senza tavole e senza essere mai
stato né in Mesopotamia e né in Persia. Non aveva la minima idea su come
cominciare, né da dove.
“Cosa pensavi, quando hai accettato la scommessa?”.
“Non lo so. Pensavo di potercela fare, evidentemente. Però mi servirebbero le
tavole.”
“Vai laggiù, in Oriente. Potresti lavorare sul posto e farti un’idea migliore riguardo
alla cultura antica.”
“Non voglio mettermi a fare l’archeologo. Mi servono solo delle copie. Già, le copie
delle tavolette, poi non ti disturberò più.”
Mi alzai, sconfortato. “Senti, c’è questo olandese, si chiama Cornelis de Brujin…ha
copiato e disegnato molte delle iscrizioni di Persepoli.”
“Ne hai alcune?”.
“Sì, ma…sono soltanto copie. È come studiare, al posto di un bel quadro, la copia
fatta da un apprendista, pur bravo, ma apprendista.”
“Non chiedo altro. Mi farai avere quelle copie?”
“Sono solo poche e confuse. Sul serio, perché non vai laggiù? Potrei
accompagnarti, è un luogo meraviglioso e…”
“Mi farai avere quelle copie?”.
Mi guardava con uno sguardo talmente spaesato che non potei far altro che
annuire. Lui se ne andò, soddisfatto, mentre il cielo si copriva di nubi.
Siccome avevo un ombrello, lo aprii.
Aprile 1802
Göttingen, Germania
La maggior parte di quegli studiosi ancorati all’idea che di scrittura si trattasse,
erano arrivati a ben poche conclusioni. Le iscrizioni di Persepoli presentavano ben tre colonne separate, con caratteri
dissimili. Era noto che verso il 540 AC Ciro il Grande avesse sconfitto i Babilonesi,
dunque alcuni – ed io per primo, nei rari momenti in cui mi ero abbandonato alla
tentazione – avevano ipotizzato che almeno una delle tre colonne fosse nella lingua
dei conquistatori. E perché non quella centrale, considerato che il centro è di per sé
sinonimo d’importanza?
Si era poi notato un cuneo, un carattere che si ripeteva più volte. Si era pensato
che questo potesse indicare la parola “re”, specchio della megalomania di quei
grandi re persiani. Questo era tutto: ed era molto poco. Anni di studi e nemmeno
uno studioso era riuscito a stabilire se si dovesse leggere da destra o da sinistra: e
quel Grotefend – pazzo! – sperava in meno di un anno, di giungere a qualche
risultato?
Stavo tornando a casa, una sera, la strada rischiarata dalla luce dei lampioni,
quando notai, proprio sotto la porta della mia casa, una busta.
La presi in mano con circospezione e, quando vidi chi me l’aveva inviata, la gettai
sul tavolo e la lasciai a giacere laggiù. Marie sussultò e mi corse incontro:
“Che hai? Non fare quella faccia, ti prego.” La guardai per un momento negli occhi
chiari. Aveva il viso sporco di polvere, o forse era farina. Era qualche tempo che
aveva la fissa di cucinare dolci ed io ero la cavia di ogni sua sperimentazione.
“Sei stanco, tesoro?”. Mi fece sedere al tavolo, poi mi coprì di baci. Le accarezzai il
volto, ma avevo la testa da un’altra parte.
Non so come mi venne in mente quell’idea, fatto sta che dopo pochi secondi le
domandai, lo sguardo luminoso: “Amore…ti andrebbe di fare un viaggio?”.
“Che cosa?”.
“Un viaggio, sì. In Oriente. Tu non ci sei mai stata. Vorrei portarti laggiù, farti sedere
su un antico trono persiano, proprio come una principessa.” Di norma non ero così
sdolcinato, ma avevo bisogno che lei mi dicesse di sì. Tanto per avere la scusa di
non aprire la lettera che stava sul tavolo.
“Oh tesoro.” Commentò lei. Poi sparì in cucina, senza dire una parola.
“Dico sul serio.” Esclamai. Ma lei, niente. Udii soltanto una risatina dalla stanza
accanto.
Siccome la lettera sul tavolo mi fissava con sguardo torvo e non avevo più via di
fuga, la strappai con foga via dalla busta e me la misi sulle ginocchia. Poi,
cominciai a leggere.
Carissimo,
ti scrivo per informarti dei passi in avanti che ho compiuto. Non che siano molti, in
verità, ma c’è qualcosa che mi spinge ad andare avanti. Sento di potercela fare.
Ieri notte sono stato tutto il tempo incollato a quelle copie che mi hai fatto pervenire
– e non smetterò mai di ringraziarti per questo. Sentivo come un formicolio sulla
punta delle dita. Ogni volta che toccavo quelle copie, che percorrevo con le mani le
stravaganti forme di quei cunei, ecco che sentivo, sentivo qualcosa di magico. Non sono mai stato in Oriente, ma ieri notte, con la mente ero là. In mezzo ai
grandi re, nelle città persiane e della Mesopotamia, ad ammirare il fiume insieme a
te. Poi, ho capito. Ho capito cosa tanto mi dava da pensare, nel percorrere quei cunei
con la mano. L’ho urlato ad alta voce, tanto che il proprietario di casa mia s’è
svegliato per accertarsi che fosse tutto a posto. Ed era tutto a posto, assolutamente
tutto a posto.
Signor mio, ecco cosa m’aveva fatto tanto sobbalzare: l’angolo di quei piccoli uncini
è sempre rivolto verso destra. L’uomo, lo scriba che millenni fa incise sulle tavolette
quei piccoli segni, lo fece da sinistra verso destra – e dunque gli angoli dei cunei
sono rivolti in quella direzione. Se si tratta di una scrittura – e ne sono sempre più
convinto – allora si legge proprio come la nostra. Nella stessa direzione.
La lettera finiva così, senza nemmeno un cenno di saluto. Ansimando, frugai in giro
per il mio studio, e tirai fuori alcune delle copie che ancora non avevo dato a
Grotefend. E mi accorsi con sorpresa che aveva ragione.
Maggio 1802
Samarra, Mesopotamia
Marie non si era ancora svegliata, così pensai bene di scendere in strada da solo,
per pensare un po’.
Frenetica come poche, Samarra era un miscuglio di rumori, odori, colori, un
mercato vivente, una mostra d’arte futura, in cui le persone si amalgamavano con
l’ambiente e formavano un tutt’uno. Gli odori delle spezie mi solleticavano il naso.
Un arabo sventolava la mano per attirare i passanti alla sua bancarella ed io mi
avvicinai, incuriosito. Vendeva piccoli monili preziosi, collane in ossidiana e con
fregi dorati, il tutto a poco prezzo, come se ne disponessero in quantità infinite.
Ne presi una con il proposito di donarla a Marie, ma appena la potei esaminare
meglio, decisi che sarebbe stato un piccolo segreto tutto mio.
Quella collana non era stata intagliata di recente, ma secoli e secoli prima. Chiesi in
arabo al venditore dove l’avesse trovata e lui mi riferì indicazioni confuse.
C’era una collinetta, poco fuori città, dove i venditori trovavano pietre preziose,
anfore, cocci di vasi ormai irreparabili. Il mio cuore batteva forte alle sue parole.
Quando tornai nella mia stanza, Marie dormiva ancora.
La svegliai, lei grugnì e fece per darmi un pugno. Io lo schivai e lei si mise a ridere.
“Marie, andiamo. Non ti dispiace scavare sotto il sole, vero?”.
Arrivammo qualche ora dopo nei pressi della collinetta. Avevo pagato l’arabo
perché ci portasse lì, mentre Marie si lamentava per la sete e per il caldo. Io e il
venditore la prendevamo in giro bonariamente, consapevoli che lei, comunque, non
ci avrebbe capito.
Scendemmo sulla collinetta, fra terra rossa e sabbia fangosa. Come un cagnolino,
iniziai a scavare a mani nude e mi accorsi che bastava andare poco sotto il livello
del suolo per trovare cocci e oggetti di vario tipo. “Per dei cocci siamo venuti? Mi avevi promesso un trono da regina!”. La zittii con
uno sguardo e chiamai l’arabo a scavare con me. Marie ci allungò le due pale che
mi ero portato dietro, poi cercò un riparo all’ombra, cercando di sedersi a terra, ma
senza sporcarsi il vestito.
Arretrai di qualche centimetro. L’uomo accanto a me non parve capire. Avevo visto,
avevo visto, sì…c’era qualcosa, là sotto, e brillava.
Scintillava di una luce opaca, ma scintillava. Con una foga mai sperimentata prima,
come un bambino alle prime armi con la vita, ecco che scavavo, forsennato,
gettando la terra alle mie spalle, il volto coperto di sudore, l’arabo che mi aiutava
senza comprendere.
Ed ecco. “Lo vedi?” gridai a mia moglie. Lei si calcò il cappello sul capo e si
avvicinò.
“Lo vedo.” Sorrise, battendo le mani.
Mi aiutarono entrambi a tirarlo su. Ci mettemmo una decina di minuti, per paura di
romperlo o di danneggiarlo. E infine, dopo millenni, lo riportammo alla luce del sole.
Un piccolo idolo d’oro massiccio, decorato di pietre preziose. Un dio dal nome
sconosciuto che un popolo antichissimo aveva scolpito nell’oro.
“Oh, mio Dio…” sussurrò Marie. Lo deposi delicatamente sulle mie gambe e lo
ammirai.
Poi esclamai: “Continuiamo a scavare.”
Agosto 1802
Samarra, Mesopotamia
Non so come, Grotefend mi aveva trovato. Mi aveva spedito una lettera all’albergo
ed io, ingenuo, l’avevo aperta. Non l’avessi mai fatto.
Carissimo,
ho sentito dei tuoi preziosi ritrovamenti in Oriente. Sono così felice, amico, qui non
si fa altro che parlare di te e di quell’oro antico tremila anni.
Ed io, intanto, rimango qui a scervellarmi sul significato di questi segni.
Non ho un dizionario, né una traduzione su cui poter contare, ma soltanto un’idea.
Forse un’idea assurda, sì. Eppure, perché non provarci?
Non sapevo da che parte cominciare, così mi sono chiesto: cosa mai potrebbero
aver voluto scrivere, gli antichi persiani, su un monumento funebre?
Così, sono andato a fare una visita al cimitero. Molti pensano che sia un luogo
tetro, ma invece credo sia uno dei luoghi più potenti e significativi, perché racchiude
la nostra storia, la storia delle persone che ci hanno portato ad essere ciò che
siamo.
E in ognuna delle lapidi, si ripeteva sempre la stessa formula: “riposa in pace” e poi
il nome della persona.
Perché non potrebbe essere stato lo stesso, tremila anni fa? Sia chiaro: non ho idea di che cosa sia scritto in quelle colonne. Le mie sono ipotesi
basate sulla psicologia e sulla conoscenza dell’essere umano, potrei sbagliarmi,
ma forse ho ragione.
Se viene più volte ripetuta una parola, e poniamo che questa parola sia veramente
“re”, allora perché non potrebbe essere accompagnata dal nome del re in questione
e preceduta da una formula simile al nostro “riposa in pace”?
Il primo problema che mi si è presentato è questo: se la mia teoria è giusta, allora
perché vi sono due cunei differenti ad accompagnare la parola re? E soprattutto,
come mai questi due diversi cunei non sono mai separati, ma sempre vicini?
Che il monumento sia dedicato a due re differenti? No, non è possibile.
E allora, ho capito. Non si legge forse nell’Iliade che Achille era il Pelide, e
l’Odissea non ha forse come protagonista il Laerziade Odisseo? L’altro cuneo che
accompagna la parola “re”, non è altro che il nome del padre, anch’esso re.
Dunque ho ricavato uno schema simile a questo:
X (nome del padre) re, figlio di Z.
Y (nome del re a cui è dedicato il monumento) figlio di X, re…
C’è quindi un gruppo di cunei che significa “re”, un’altro che significa “figlio” ed
alcuni cunei che invece rappresentano i nomi dei re in questione.
Il padre di X, il cosiddetto Z, non è però accompagnato dall’apposizione regale.
E questo, mio caro, è stato davvero un colpo di fortuna.
Mi trovavo davanti ad una situazione familiare pressoché unica, in cui vi erano un
padre ed un figlio entrambi re ed un nonno che invece re non era.
Sono corso in biblioteca a spulciare fra gli annali greci e fra le opere dei grandi
storici che parlarono dei persiani. Avevo bisogno di trovare i nomi di quei re.
Se li avessi trovati, sarei riuscito finalmente ad avere abbastanza sillabe per poter
decifrare altre frasi, e da lì altre iscrizioni, fino a quando…
“Tutto bene?”.
“Uhm? Sì, perché?”.
“Sei chiuso lì dentro da molto tempo, ormai.”
“Tranquilla, cara. Ho solo bisogno di un po’ di tempo per me, d’accordo?”.
“Voglio andare a scavare.” Disse, imbronciata.
“Se qualcuno te l’avesse chiesto, giusto due mesi fa, ti saresti eclissata in cucina.”
“Poi mi porti a scavare, vero?”.
“Sì.” Risi. Poi lei chiuse la porta ed io ricominciai a leggere.
…fino a quando non avessi padroneggiato con sicurezza l’antica scrittura
cuneiforme.
Un groppo mi stava salendo in gola, mentre come un forsennato scartavo nomi di
re e di figli di re…non potevano essere Ciro e Cambise, perché i loro due nomi
cominciavano con la stessa lettera, mentre i cunei con cui cominciavano i nomi dei
miei due re erano differenti. Non poteva trattarsi, in generale, nemmeno di un Ciro
o di un Artaserse perché il primo nome sarebbe stato troppo corto rispetto ai
caratteri, ed il secondo troppo lungo. Restavano soltanto poche ore alla mezzanotte e due nomi di re: Dario e Serse, che
così bene si adattavano ai miei scopi.
È intuito, fortuna e una buona dose di incoscienza. Ma mio caro professore,
qualcosa mi dice che sono nel giusto e che i nomi di re antichissimi hanno iniziato a
parlarmi.
Chissà se avranno qualcos’altro da raccontare…
Ottobre 1802
L’anno scolastico era appena ricominciato e i corridoi della scuola brulicavano di
studenti in uniforme. Sulle bocche di tutti, non c’era altro che un nome, quello di
Plymouth. Si diceva che avesse già fatto le valigie ma che aspettasse a dare
l’annuncio ufficiale.
Una mattina fresca d’autunno, gli studenti si radunarono nel cortile dell’università e
osservarono il professore che, con aria mesta, s’arrischiava a passare in mezzo a
loro, carico di valigie e di libri sottobraccio. Ci furono fischi ed applausi. I giovani lo
seguirono con un mormorio generale fino al cancello scuro e pesante. Lo videro
allontanarsi con la testa bassa, sulla strada costellata di ciottoli bianchi.
Pochi minuti dopo, l’attenzione era già rivolta ad altro e di Plymouth e della sua
boria non si sentì più parlare, se non fra i professori.
Si diceva che Grotefend avrebbe di lì a poco presentato i suoi risultati
all’Accademia. Erano ancora poche basi, pochi caratteri decifrati, ma quell’uomo
c’era riuscito con un colpo di genio, intuito e sagacia, senza disporre di alcun aiuto
se non la sua mente brillante.
Da quelle piccole basi avrebbe potuto decifrare la colonna intera, e poi tradurre
anche le altre due colonne, quella in babilonese per esempio, e scoprire parole di
persone vissute migliaia di anni prima, in un altro luogo e in un’altra vita. Erano
piccoli, enormi passi.
Grotefend mi aveva chiesto di accompagnarlo all’Accademia, ma io avevo declinato
l’invito con un sorriso. Non sarei stato più lì.
Mi giunse il resoconto del suo buffo e brillante intervento che stavo osservando il
fiume scorrere accanto a me.
Lo guardavo con un misto di dolcezza e sacralità e cercavo disperatamente di
capirne le parole. Il sole stava tramontando sul fiume e di lì a poco il freddo mi
avrebbe avvinghiato le ossa.
Ma non ancora.
Fissai l’acqua rossastra e mi bagnai le dita delle mani con un sorriso.
Mi parve d’intravedere un luccichio, un bagliore nell’acqua. Sbattei gli occhi, ma
non c’era nulla.
Forse non c’era mai stato. Forse era stata soltanto un’illusione.
Dev’essere abbastanza comune abbandonarsi al sogno, laggiù, in Mesopotamia.
OMAGGIO A GEORG FRIEDRICH GROTEFEND
Ultimi articoli pubblicati:
Condividi questo contenuto
GLI ULTIMI ARTICOLI DI EUREKA: