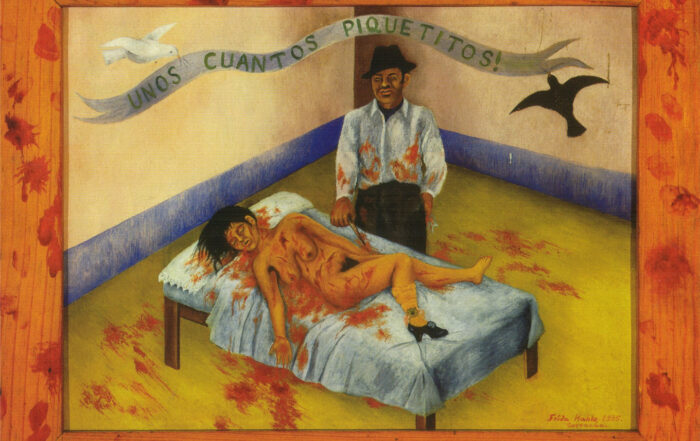Ultimi articoli pubblicati:
Narrare l’Olocausto attraverso una cinepresa è uno dei metodi più utilizzati ed efficaci per tramandarne la memoria: basti pensare a quando, appena liberati i campi di concentramento, le truppe alleate inviarono squadre di registi a filmare tutto l’orrore racchiuso dai cancelli e dal fino spinato. Vivere l’Olocausto al cinema, invece, è un’esperienza decisamente inusuale, ma da quest’anno non più impossibile: lo ha fatto Jonathan Glazer nella sua pellicola “La zona d’interesse”, Grand Prix Speciale al Festival di Cannes e vincitore di tre premi Oscar, che narra la vita quotidiana di Rudolf Höß e della sua famiglia nella area di interesse (Interessengebiet) di circa 25 miglia attorno al campo di concentramento di Auschwitz, di cui il protagonista è il comandante nei primi anni Quaranta. Una coproduzione anglo-polacca straordinaria e sconvolgente, capace di risvegliare le coscienze degli spettatori come un pugno allo stomaco: ma in cosa risiede la sua grandezza?
Per capirlo fino in fondo, forse, è necessario vivere il film stesso, calarsi nella realtà e nel contesto in cui è stato concepito.
Un’ altra esperienza decisamente inusuale, ma non impossibile.
È la mattina del primo marzo quando giungiamo al campo di concentramento femminile di Ravensbrück, nell’estremo nord della Germania, la tappa fulcro del Viaggio della Memoria di quest’anno. Ad accoglierci all’ingresso, solo freddo, ordine e un silenzio ingombrante, pieno; si palesa per la prima volta il paesaggio idillico, ma apparente che doveva camuffare il campo all’occhio esterno, con l’immenso, placido lago che si affaccia sulla vicina cittadina turistica di Fürstenberg, le alte e fitte piante, il prato di un verde pieno e carico, quasi disturbante. Un primo elemento che rimanda immediatamente alla natura artificiale e artificiosa rappresentata ne “La zona d’interesse”, dove il giardino della villetta abitata dalla famiglia Höß viene curato e abbellito ogni giorno dalla moglie del comandante, Hedwig: come lei stessa confida alla madre in visita, infatti, coltivando diversi tipi di fiori e arbusti la donna spera di ricoprire il muro di Auschwitz con cui la casa confina, in modo tale da nasconderlo. E il nascondere diviene quindi uno degli elementi principali della pellicola, che prende forme diverse a seconda del corpo che incarna: una sopravvivenza soffocante per la madre di Hedwig, una vita invece idilliaca per la famiglia Höß, fino a raggiungere il suo culmine nella modernità del finale. “Qui abbiamo tutto quello che sognavamo da quando avevamo diciassette anni, Rudolf: una bella casa lontano dalla città, cinque figli belli e sani, una vita tranquilla”, rivela un giorno Hedwig al marito. Ed effettivamente, la scena di soffocante tranquillità che costituisce il nucleo abitativo delle SS, posto appena fuori alla stessa Ravensbrück, è sconcertante e ipnotica allo stesso tempo. Impareggiabile è la maestria di Glazer nel descrivere, tramite l’uso di colori pastello patinati tipici della pubblicità di allora, quelle casette geometriche e colorate, tutte uguali, con il loro spazio di giardino intorno e, perché no, anche i giochi dei bambini sparsi attorno: come ad Auschwitz, infatti, anche nel campo tedesco la famiglie seguivano i padri nei vari spostamenti di lavoro, abitando a pochi passi da tutto quell’orrore. Dirimenti, sotto questo aspetto, sono le testimonianze di alcune sopravvissute, che raccontano del figlio di tre anni del comandante Fritz Suhren intento a giocare nel cortile di casa e, se necessario, a minacciare di morte le prigioniere polacche, in caso non svolgessero i compiti a loro affidati.
Questi aspetti consentono di sviscerare altri aspetti fondamentali de “La zona d’interesse”, che lo rendono una pellicola talmente insolita da risultare straniante: tutta la narrazione, infatti, è narrata come se fosse un film di propaganda, in cui la semplice quotidianità della famiglia Höß (definita dal critico cinematografico Giovanni Bogani, per la libertà delle riprese
e del raggio di azione degli attori, un “Grande Fratello nazista”) fa risaltare la vera, celata protagonista della vicenda: Hedwig. Alla moglie del comandante, di umili origini, è affidata la reggenza di una casa piena di servitori polacchi e la cura dei figli, che più di una volta emulano gli adulti giocando alla guerra -una situazione che li accomunava, a loro insaputa, a molti bambini internati, il cui unico divertimento era fingere rastrellamenti o controlli nazisti tra di loro-, ma non solo. Se è lei che racchiude la casa di Auschwitz in un finto paradiso terrestre, creato come un nido per la sua famiglia da copertina, questa cura incessante non la rende un personaggio ingenuo né tantomeno passivo agli eventi: dimostra infatti una crudeltà spietata nel suo rapporto con i polacchi, nonché una freddezza imperturbabile nel suo saldo proposito di abitare vicino al campo, una situazione che non la disturba affatto. Su Hedwig, infatti, il disinteresse si è incancrenito a tal punto da anestetizzarla dal mondo che la circonda, dimostrando una crudeltà bruta e spietata che è la sintesi perfetta del concetto della “banalità del male” espresso dalla filosofa Hannah Arendt nell’omonimo saggio. Lo stesso comportamento, del resto, è riscontrabile nelle ausiliare del campo di Ravensbrück, che tra le sue molteplici funzioni assunse anche quello di zona di addestramento di SS-Aufseherinnen, ossia le sorveglianti dei block nei diversi KL: delle donne giovani e spietate, dedite ad ogni sorta di cattiveria e dotate di un sadismo particolarmente spiccato nel torturare le prigioniere e i bambini, a volte neonati. Le donne naziste, inoltre, secondo le testimonianze delle sopravvissute, “specializzate” nel processo di deumanizzazione che è visibile anche nel lungometraggio anglo-polacco, dove sempre ad Hedwig viene affidato il compito di suddividere, tra gli abitanti della casa, gli oggetti sottratti ai detenuti: alla padrona di casa le pellicce più belle, alle cameriere gli abiti più consunti, mentre ai bambini cimeli collezionabili quali denti d’oro e pezzi di bigiotteria.
Superato l’ingresso al campo, ci si lascia alle spalle definitivamente la zona dei nazisti e ci si immerge nel punto di vista degli internati, una condizione che ne “La zona d’interesse” viene solo accennata tramite potentissime percezioni audiovisive registrate dal vero e poi montate minuziosamente insieme, talmente forti da oscurare anche la scena in corso: è in una maniera così coinvolgente che Glazer descrive la vita all’interno del lager, fatta di rumori, strida, urla, oggi solo in parte comprensibile dallo scalpiccio dei passi sul terreno in pietrisco, che si propaga all’infinito per la landa vuota dove una volta giacevano decine di baracche, di cui attualmente rimane solo il solco delle fondamenta. E al centro, ancora una volta, un viale simmetrico coronato da alberi piantati in parallelo.
Nascosto dietro al muro si trovavano, inoltre, le camere a gas con i forni crematori, costruiti a partire dal 1942 seguendo i dettami dell’operazione “14f13”: un “luogo adibito all’eliminazione dei pezzi”, come viene definito nel film, ambientato negli anni in cui si stavano ancora sviluppando i dettagli tecnici della soluzione finale. “Pezzi”, come erano già stati definiti i prigionieri del lager in “Vita e destino” di Vasilij Grossman: pezzi di pane, pezzi di sterco, pezze ai piedi. Tutte le definizioni più offensive e deridenti erano accettabili, pur di allontanarli da quell’umanità che voleva essere strappata loro a tutti i costi; un’operazione che ai nazisti non riuscì mai di completare. “Nessuno è sopravvissuto da solo”, dicono quasi tutti gli ex deportati: ed era infatti con la solidarietà e la vicinanza che le donne di Ravensbrück cercavano di tirare avanti, scambiandosi ricette, recitando poesie, riservandosi gesti di affetto a chi aveva appena perso un caro, un genitore, un figlio. Sono queste le forme di resistenza fatta di sottecchi che caratterizzava la vita comunitaria del campo, e che ne “La zona d’interesse” sono poche scene girate con la termocamera, dal significato volutamente oscuro ed ermetico, di una bambina ispirata alla figura di una giovane dissidente polacca realmente esistita, di nome Alexandria, che distribuisce di notte cibo ai prigionieri.
Una volta conclusa la loro vita nelle docce di Zyklon B, quindi, i cadaveri delle prigioniere venivano bruciati nel forno crematorio antistante tutt’oggi esistente, mentre le ceneri venivano sparse nel giardino lì appresso oppure nel lago, che costeggiava il retro del campo. Oggi, di fianco al crematorio, giace una distesa di rose rosse che costituisce una tomba per tutte le donne uccise e che ridona loro quell’umanità e femminilità ingiustamente sottratta: se i fiori sgargianti e peculiari del giardino degli Höß, concimati con le ceneri dei prigionieri gasati, rappresentano l’ennesimo modo per deumanizzare gli internati e considerarli un mero strumento, arrivando addirittura a considerare il loro giardino “più ariano” dei prigionieri, a Ravensbrück quei fiori, insieme ai simbolici garofani bianchi, ricoprono l’intero memoriale, stavolta al servizio del ricordo di quei corpi che non esistono più, e della cui scomparsa, testimoniata in extremis dalle ceneri che uscivano dal camino, gli abitanti di Fürstenberg non hanno voluto essere testimoni, ma ignorarla, costruendo un muro di menzogne uguale a quello di Hedwig. “Tutti ora sapete, tutti ora siete coinvolti in questo orrore”: questo sembra urlare la statua di donna ammutolita che ora guarda il lago e il piccolo paesino, mentre tiene in braccio il cadavere di una compagna. Ed è forse qui, nello sguardo duro di questo monumento, che si racchiude anche una domanda fondamentale scaturita dalla visione del film di Glazer: per quanto ancora la famiglia Höß avrebbe vissuto così? Fino a quando avrebbero perpetrato la drammatica commedia?
Forse ancora per poco, ma molto probabilmente per sempre: è ciò che hanno fatto i figli, descrivendo il comandante come un eroe di guerra, e quello che, in generale, tendono a fare tutt’oggi coloro che minimizzano o addirittura cancellano quell’orrore, nascondendosi dietro l’indifferenza. È proprio in questo messaggio che lo scopo del film e quello del memoriale del campo coincidono: coltivare una forma di memoria che faccia rivivere ciò che è stato senza feticizzare il dolore, che renda oggettivamente i fatti e che, allo stesso tempo, faccia nascere nell’uomo sentimenti sconvolgenti e traumatizzanti, che facciano ricordare quella visita per sempre.
Al di là delle parole, sono i sensi a cogliere in maniera più nitida e profonda quello che è stato vissuto; se per risvegliare le coscienze è necessario un pugno allo stomaco, allora Glazer lo ha decisamente tirato, immergendo lo spettatore nella stessa realtà riscontrabile dal vero con quella forma di memoria che più si impregna nel cervello umano: la banale quotidianità.
Condividi questo contenuto
GLI ULTIMI ARTICOLI DI EUREKA: