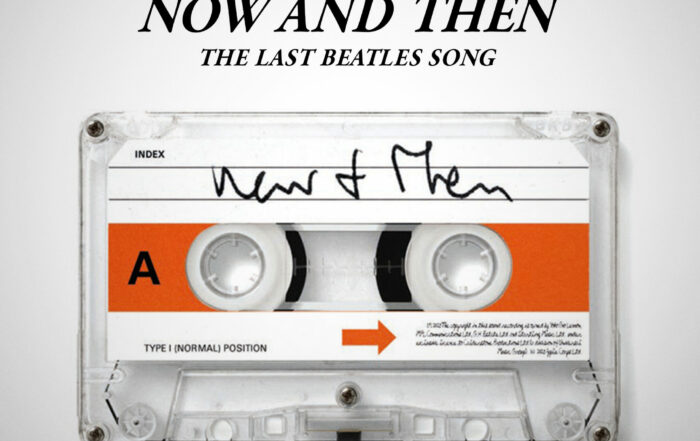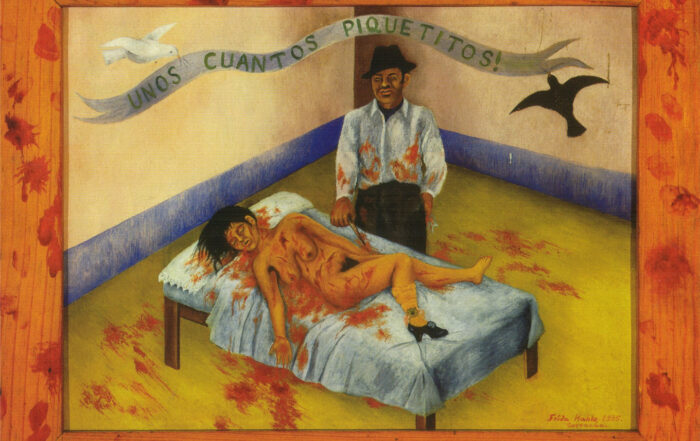La Follia di Vivaldi
Data: 13 Dicembre 2022
Tag: Racconti
Di: Elena Mora

DOTT. B. FLANNERY, SPECIALISTA IN PSICOLOGIA DEL TEMPO
C’erano carta, penna e calamaio sulla scrivania.
Fuori uso ormai da molti anni, appena svitò il tappo dell’inchiostro e immerse le dita fredde in quella materia nera e aggrovigliata, sentì un fremito vivo lungo la schiena. Ora le sue mani, le sue dita erano completamente nere. La scrivania era costellata di piccole macchie e lui, cercando di pulire, sporcava ancora di più.
L’inchiostro si spandeva, si allargava, arrivava a toccare il soffitto e poi negli angoli più bui del suo corpo, lo sentiva formicolare tra le dita dei piedi di cui non ricordava il nome.
Non era la prima volta che entrava in quell’ufficio. Ricordava, ricordava bene la mobilia antica e pretenziosa e i ritratti dei dodici Cesari appesi alle pareti neanche fosse stato lo studio dell’Azzeccagarbugli. Ricordava anche la penna e l’inchiostro, il grammofono non più in funzione che serviva soltanto per scopi decorativi. Una pioggia di luce cadeva dal lampadario penzolante dal soffitto di legno scuro e inondava la stanza di luce pulita, piatta, bianca, contro il nero inchiostro che ormai tiranneggiava.
Aspettava là dentro da almeno mezz’ora. Non lo sapeva, non aveva un orologio: gliel’avevano fatto lasciare all’ingresso. Anche questo era un particolare che ricordava: nessuno poteva entrare nello studio con un orologio indosso. Il tempo è una prigione, gli avevano detto. Se lo vediamo passare, ci rovina e ci uccide. Se invece lo ignoriamo, gettiamo via tutti gli orologi, il tempo ritorna quel che è: una mera invenzione dell’uomo che l’uomo può distruggere e sopprimere quando vuole.
Gli avevano detto anche che, se è vero che il tempo e lo spazio sono la stessa cosa, annullando il tempo si annulla lo spazio e allora il quadrato ristretto della cella diventa infinito, diventa il mondo intero, tutto quello che possiamo desiderare.
Questo è un allenamento, pensava. Se non riesco neppure a vivere senza orologio, come penso di vivere senza tempo?
È per questo che sei venuto qui. Per impararlo. Quindi taci e cerca di rimediare al disastro che hai provocato.
Chiese alla ragazza bionda qualche pezzo di carta. Lei si inabissò nei meandri di un corridoio altero e ne uscì fuori poco dopo, con un rotolo tanto lungo da poter abbracciare l’Equatore senza stirarsi troppo. La ringraziò con un cenno del capo, ma lei non se ne andava ancora. Forse per curiosità, forse per sfida, voleva sapere che cosa ne avrebbe fatto, del rotolo che aveva portato.
Cercando di allungarsi abbastanza da coprire la macchia nera sulla scrivania, riprese in mano la penna e scribacchiò qualcosa sul rotolo di carta.
Poi lo porse alla ragazza che, stupita, vide un piccolo cuore contornato d’inchiostro sporgersi verso di lei. Lo fissò, incuriosita. Gli angoli della sua bocca si inarcarono e rivelarono un dolce sorriso. Rimase ancora per qualche istante prima di chiudersi la porta alle spalle.
Assicuratosi che se ne fosse andata, e di averla distratta abbastanza, si chinò curvo sulla scrivania e prese a cancellare con foga la macchia, bagnando la carta con l’acqua per dissipare ogni traccia dell’incidente.
Proprio quando la scrivania stava finendo di asciugarsi, la ragazza entrò di nuovo. Lui sollevò le mani in alto, perché oramai era fin troppo abituato a portare le mani in alto quando entrava qualcuno con una fedina penale più pulita della sua.
La giovane inclinò la testa ed esclamò: “Avete le mani nere, signore.”
Lui se le guardò con un pizzico d’orrore, temendo che il suo segreto fosse stato scoperto, che la ragazza l’avrebbe denunciato al dottore, che l’avrebbe citato per danni e non l’avrebbe aiutato. Nell’ipotesi più catastrofica, il dottore sarebbe entrato con una pistola carica e, subito conscio dell’accaduto, gli avrebbe sparato in testa.
Si vedeva già con un buco nella fronte, da cui colava sangue nero e grumoso.
“Questo è il marchio, vero?” domandò la ragazza.
Stavolta fu lui ad inclinare il capo. Non tanto per la sorpresa, quanto perché lei gli stava offrendo una comoda via di fuga.
“Il marchio?”.
“Sì, quello che fanno ai condannati prima del processo. Così, dovunque vadano, saranno riconoscibili e non potranno scampare al destino.”
Gettò la testa all’indietro e si mise a ridere. Lei lo guardava contrariata, perché le sembrava che fosse una questione troppo seria per suscitare ilarità.
“Come l’hai saputo?” chiese, dopo avere interrotto la risata.
“Me l’hanno riferito. Pensavo che fosse una voce di corridoio, ma ora che vedo le vostre mani…”
“Ebbene, signorina, hai ragione. Non dirlo a nessuno, mi raccomando.”
“Non è un segreto che i clienti del dottore siano dei condannati. Si occupa proprio di questo.” Poi, aggiunse, dopo qualche attimo di riflessione: “Ma voi dovete avere proprio fatto qualcosa di male, se vi hanno impresso il marchio. Non l’ho mai visto sulle mani di nessun altro.”
L’uomo sorrise e le fece cenno di avvicinarsi. Lei, guardinga, obbedì.
“Oh, a dire il vero ce l’hanno tutti. Ma c’è chi ha trovato il modo di nasconderlo.”
“E perché voi non lo nascondete?” domandò, sempre più curiosa.
“Perché vado fiero di quel che ho fatto. E il marchio mi ricorda il mio passato.” “Dunque, non siete pentito.” Il suo tono era un misto fra il rimprovero e la curiosità, come se due persone stessero nascoste dentro di lei e, ogni tanto, pronunciassero la stessa frase in modi completamente differenti.
“Non sono un pentito, no. Sono un rivoluzionario.”
“Rivoluzion…oh!” gridò la fanciulla. Fece un paio di passi indietro e si portò le mani nei capelli, tanto per esprimere teatralmente tutta la sua incredulità.
Stava imbastendo una montagna di bugie sopra l’altra, ma più si allontanava dalla verità e più la ragazza pareva credergli. Ormai, pendeva dalle sue labbra.
“Dunque facevate parte dell’affare Yosemite. Avete organizzato tutto voi?”.
“Io e un paio di amici. Non mi pento di quello che ho fatto, sai? Eravamo giornalisti e ci hanno tolto la libertà di scrivere quel che volevamo. Non potevamo permettere che la passassero liscia, dopo tutto il sangue che hanno versato. Donne, bambini, elicotteri che sganciano bombe senza alcuna logica…potevamo forse stare a guardare?”.
Le parole si fermarono in gola alla ragazza, che da una parte sentiva il desiderio di seguire quel coraggioso ribelle dovunque la portasse e dall’altra manteneva l’umano desiderio di restare viva e senza problemi di sorta.
“Comunque” continuò lui, con un tono drammatico “comunque ci hanno presi. E mi assumo tutte le mie responsabilità. Forse, forse un giorno qualche persona aprirà gli occhi e seguirà i nostri passi…”
La ragazza prese quell’esclamazione sospesa come un appello diretto a se stessa. Fissava gli occhi infervorati di quell’uomo che portava il marchio sulle mani, sfoggiandolo senza nasconderlo, perché fiero di aver combattuto per la libertà… Continuò a pensarci anche dopo che il dottore, finalmente, fu entrato nella stanza con la sua valigetta di pelle nera e lei dovette tornare alla vita normale.
Il dottor Flannery era un uomo sulla sessantina, con una calvizie diffusa e un’ingiustificata passione per tutto ciò che era antico. Appena fu entrato, si avvicinò al grammofono e vi armeggiò per una decina di secondi. Dopo un bizzarro stridore iniziale, una musica dolce dilagò per tutta la stanza, antica e moderna come se fosse stata senza tempo.
“Ti piace? Credo che sia Vivaldi. Ho uno smisurato amore per Vivaldi e non riesco a capire come mai i giovani d’oggi non vadano ai suoi concerti.”
Evitò di fargli notare che forse i giovani non andavano ai suoi concerti perché Vivaldi non c’era più, pensando bene che, assecondandolo, forse l’avrebbe potuto aiutare. “Stavo cominciando a preoccuparmi. Non arrivava più.”
Prima di rispondere, si sedette alla sua scrivania, con tutta la calma del mondo. Esaminò l’alone scuro di una piccola macchia e probabilmente trasse le sue conclusioni. Sospirando, richiuse la boccetta d’inchiostro ed esclamò: “La prossima volta che ti tocca nascondere qualche disastro” e alzò la boccetta per aria “abbi almeno la cura di richiudere l’inchiostro”.
Non riuscì ad afferrare se il significato di quelle frasi fosse unicamente riferito alla boccetta, oppure in senso metaforico anche alla sua situazione personale.
“Non arrivavo più? Sì, può darsi. E questa cosa ti ha dato fastidio?”.
“Certo che no.”
“Sii sincero, o non potrò aiutarti.”
Rifletté per qualche secondo, indeciso fra l’essere gentile o dire la verità, opzioni che solitamente non vanno particolarmente d’accordo.
“Sì, diciamo che iniziavo ad essere infastidito. Credevo di passare qui tutto il giorno ad aspettare.”
Il dottore si alzò in piedi, corrucciando la fronte come un maestro che rimprovera un allievo renitente o come un generale che coglie i suoi uomini nell’atto di scappare. “Ah, beh, qui sta il punto. Temevi di aspettare qui tutto il giorno: come farai ad aspettare per tutta la vita, fra l’altro non in uno studio accogliente come il mio, pieno di distrazioni quali l’inchiostro, ma in una piccola cella umida e buia?”.
“Sono qui per scoprirlo.”
Qualche settimana prima, il poliziotto che l’aveva arrestato, avendo in qualche misura pietà di lui, gli aveva confidato di avere un amico, tale dottor Flannery, che era dottore in una disciplina da lui inventata e di cui era anche l’unico esponente. Accoglieva i futuri ergastolani nel suo studio e li preparava alla reclusione a vita. Nemmeno il poliziotto aveva del tutto fiducia nei metodi del dottore, né nel loro funzionamento, ma gli aveva detto che forse provare valeva la pena.
E allora eccolo lì, in quello studio. Ora che vedeva quell’omuncolo piccolo e infervorato, che blaterava senza senso parole che riguardavano il tempo o qualcosa del genere, perdeva la fiducia ad ogni minuto che passava. Poteva impiegare quel tempo che gli rimaneva prima del nulla per stare con Kate, ma forse ora non l’avrebbe più voluto vedere. Oppure, avrebbe potuto conoscere meglio quella ragazza bionda che gli aveva portato il rotolo di carta, perché non si aspettava da lui l’infinito, né un’eternità da passare insieme.
“Lo sai” disse il dottor Flannery “che cosa ti ha dato tanto fastidio?”.
“Immagino che questa sia una domanda retorica.”
“Esatto. Tu eri qui con uno scopo preciso, ossia vedere me, incontrare me, risolvere i tuoi problemi. Stavi aspettando.”
“Sì, mi sembra che il ragionamento sia corretto.”
“E invece no!”. Il dottore sbatté un pugno sul tavolo, facendo traballare pericolosamente la boccetta d’inchiostro. “Fra pochi giorni andrai in prigione per sempre. Per sempre. Non ne uscirai mai più, capito? Mai. Se passi tutta la vita ad aspettare qualcosa, allora hai perso in partenza.”
“Sono conscio del fatto che non uscirò più. So che la mia cella sarà l’ultima immagine che vedrò del mondo.”
“No che non lo sai. Se lo sapessi, non saresti qui.” Prese a girare intorno alla scrivania, intorno alla sedia, intorno a tutta la stanza, finché non gli ebbe fatto girare la testa abbastanza da ascoltare senza interrompere.
“Un uomo – non devi essere per forza tu, prendiamo come esempio un uomo qualsiasi – entra in prigione con le parole del giudice che gli ronzano nelle orecchie.
Tre anni di carcere, bam, martelletto sullo scranno. Cinque anni, bam, vent’anni, trenta…oppure, la vita intera. Il nostro uomo che non sei tu entra in prigione. Il cervello sembrerà una macchina tanto complicata, ma a dire il vero è uguale per tutti. La speranza non è altro che una serie di impulsi nervosi. Tre anni di carcere: il nostro uomo vive, sopporta, perché sa che fra tre anni vedrà la luce. Allora il tempo è suo amico, perché più passa e più si avvicina il giorno della rinascita. Ma se il nostro uomo che non sei tu entra in prigione sapendo di non uscire mai più, il suo cervello non può elaborare le cose allo stesso modo. Non può contare i giorni che passano, perché finirà per impazzire. Non può contarli perché non serve a nulla: ogni giorno che passa non è un passo verso la libertà, è una parte infinita dell’infinito. Mi segui?”. “No.”
“D’accordo, d’accordo. Se tu dividi l’infinito per due, ciascuna metà dell’infinito sarà…”
“Infinita.”
“E se lo dividi per tre, ciascun terzo di infinito sarà…”
“Infinito.”
“E se dividi l’infinito per tutti i giorni del mondo, i giorni saranno…”
“Infiniti.”
“Capisci che voglio dire? Ogni giorno diventa un ergastolo. Ogni giorno diventa tanto lungo da non poterlo sopportare, da farti impazzire.”
“Capisco. E dunque, che mi resta da fare? Accorciare l’infinito, porre fine alla mia vita?”.
“Non essere così pessimista. La cosa da fare è annullare il tempo.”
“Il tempo? E come posso annullare il tempo?”.
Sembrava che finalmente il dottor Flannery stesse cominciando a ragionare, che stesse arrivando al punto del problema, quando improvvisamente cambiò argomento. Senza nessuna connessione con il dialogo che stavano illuminando a poco a poco, cominciò a narrare una storia di maghi che sputavano fuoco e di principesse che imprigionavano le streghe.
Non appena realizzò ciò che era successo, sbatté le palpebre per due volte. Sentì un formicolio attraversargli la mano, che cominciava pericolosamente a chiudersi a pugno. Ora che cominciavano ad intravedere la luce, il dottore cambiava argomento, narrava una fiaba per bambini e non sembrava intenzionato a recuperare il filo del discorso.
Infinito, infinito diceva lui. E ora davvero aveva intenzione di favoleggiare per sempre? Non aveva tempo per questo. Non aveva tempo per questo, o forse aveva tempo anche per questo, dato che di lì a poco avrebbe avuto tempo per tutto, per tutti e per tutte le generazioni a venire. Venite da me, vendo tempo! Ne ho a bizzeffe e non so come impiegarlo! Magari tu potresti utilizzarlo meglio di me, che non so che farne. Venite, vendo tempo, siate buoni, comprate, comprate. Non costa tanto: non costa niente, a dire il vero. Fate una buona azione e ci guadagnate. È l’offerta migliore che potesse capitarvi, dopotutto. Venite, non perdete tempo; anzi, perdetelo, se volete, dopotutto non sono io a giudicare le vostre vite. Per quanto mi riguarda, perdete tutto il tempo che potete perdere, perdetelo in giro, perdetelo a farvi la guerra, perdetelo a litigare, perdetelo a innamorarvi delle persone sbagliate, perdetelo a perseverare nei vostri errori. Ah, no. No, no, che dici? Che dici? Pazzo, sei? Sì, forse sei davvero un pazzo.
Taci, adesso. Che ne sai, tu? Sei un povero condannato. Non è buffo? Ci sono due pene al mondo che vengono comunemente reputate come le più terribili: la morte, cioè togliere tutto il tempo. E l’ergastolo, cioè avere tempo infinito ma non poterlo usare.
Taci e ascolta. Sembra una storiella per bambini, ma forse le favole sono quelle più difficili e più complesse. Gramo destino, quello delle storie per bambini. Le leggiamo da piccoli e cogliamo soltanto il loro significato letterale; e poi da adulti, quando le potremmo capire davvero e potremmo lasciarci cambiare da esse, le lasciamo in un angolo perché ci reputiamo troppo vecchi e saggi. Pensava questo, mentre ascoltava il dottore.
Pensava questo, così decise di fidarsi. Ascoltò le gesta del cavaliere sul campo di battaglia e poi l’arrivo della fata, che chissà come mai si immaginava con il viso della ragazza bionda.
Rimase cullato nel suo torpore. Forse si era addormentato ad occhi aperti. Stava sognando? Sì. No. Non lo sapeva. Dopotutto, anche il sogno più assurdo spesso sembra reale. E quando riaprì gli occhi – che forse erano già aperti, forse no – osservò la finestra spalancata.
Il sole era ancora al suo posto nel cielo. Esattamente uguale a come l’aveva lasciato. “Dottor Flannery!” disse. “Credevo che fossero passate ore. E invece il sole è allo stesso posto e…”
Intravide la ragazza bionda oltrepassare il corridoio. Si era cambiata: ora indossava un vestito azzurro con le pieghe e sorrideva. Anche l’acconciatura era diversa: uno chignon alto e robusto che le sovrastava il capo.
Entrò nella stanza e si avvicinò a lui.
“Ah no!” sorrise la ragazza. “L’orologio non potete tenerlo qua dentro.”
“Che cosa? Come? No, io te l’ho già dato, ricordi…?”.
La ragazza bionda gli fece un sorriso mesto. “Niente scuse, datemi l’orologio.”
Si osservò il polso. Era vero. Durante il sonno, qualcuno doveva averglielo rimesso… Strinse gli occhi per focalizzare le lancette. Ricordava di aver guardato l’ora, prima di entrare dal dottore: l’orologio sembrava essersi fermato su quell’attimo di tempo. Dopo molte ore che era in quello studio, le lancette erano allo stesso posto. “Datemelo, su.” Con un sospiro, lo sfilò dal polso. Fissò la ragazza, cercando risposte. “Il dottor Gray arriverà fra poco. Chi avete detto di essere?”.
“Il dottor Gray? Chi è il dottor Gray?”.
“Avete preso appuntamento con lui qualche giorno fa, ricordate?”.
“Io avevo appuntamento con il dottor Flannery!”.
“Flannery! Oh, no” rise la ragazza. “Flannery è morto da molti anni ormai.”
Si fissò le mani. Ogni traccia d’inchiostro era sparita e così anche sulla scrivania non c’erano più macchie.
“Non può essere…” disse.
“Che cosa non può essere? State bene, signore?”.
Prese in mano la boccetta d’inchiostro. Non ne mancava nemmeno una goccia. Appena svitò il tappo e immerse le dita fredde in quella materia nera e aggrovigliata, sentì un fremito vivo lungo la schiena.
Ora le sue mani, le sue dita erano completamente nere. La scrivania era costellata di piccole macchie e lui, cercando di pulire, sporcava ancora di più.
L’inchiostro si spandeva, si allargava, arrivava a toccare il soffitto e poi negli angoli più bui del suo corpo, lo sentiva formicolare tra le dita dei piedi di cui non ricordava il nome.
Non era la prima volta che entrava in quell’ufficio, no.
Ci era già stato molte volte, infinite volte, perché era quello il suo ergastolo.
Ma già ora non se ne ricordava più.
“Vivaldi” disse una voce alle sue spalle. “Perché i giovani di oggi non vanno ai suoi concerti?”
Condividi questo contenuto
GLI ULTIMI ARTICOLI DI EUREKA: