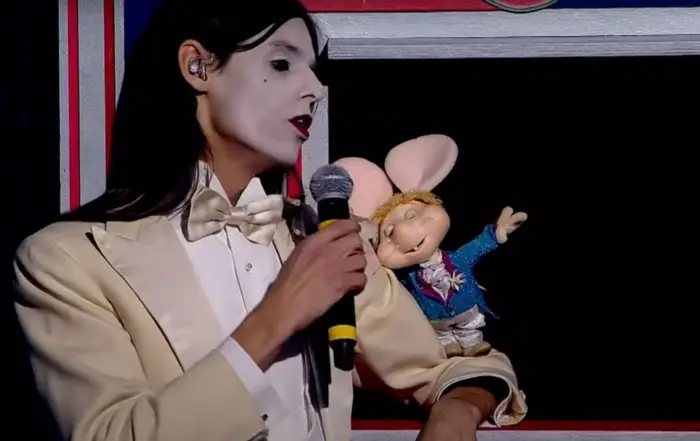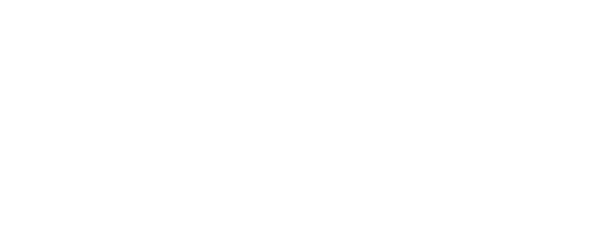Elaborati vincitori del premio Julian Assange

Pubblichiamo di seguito gli elaborati dei tre studenti che si sono classificati sul podio per il premio Julian Assange, assegnato dal nostro comune per i migliori testi sulla libertà di stampa.
Lorenzo Giovati, 1° classificato
La libertà di stampa, pilastro di ogni democrazia autentica, sta vivendo una fase di profonda crisi in Italia. Sancita dall’articolo 21 della Costituzione, che garantisce al cittadino la libertà di espressione in ogni sua forma, rappresenta non solo un diritto fondamentale, ma anche una condizione imprescindibile per un’informazione trasparente e di qualità. Tuttavia, il panorama attuale è segnato da preoccupanti regressioni. Secondo il rapporto 2024 di Reporter Senza Frontiere, l’Italia è scesa al 46° posto nella classifica mondiale sulla libertà di stampa, perdendo cinque posizioni rispetto all’anno precedente. Questo declino non è casuale, ma riflette problematiche strutturali, culturali e, forse, anche politiche che mettono in pericolo l’indipendenza del giornalismo e, di conseguenza, il diritto dei cittadini a essere informati in modo corretto e completo.
Un aspetto particolarmente preoccupante riguarda le recenti iniziative legislative che minacciano l’autonomia dei media. Ad esempio, la proposta di legge avanzata nel 2024 prevede sanzioni penali per i giornalisti che pubblicano informazioni ottenute illegalmente, anche se di rilevante interesse pubblico. Questa misura potrebbe dissuadere i professionisti dell’informazione dal condurre inchieste su temi sensibili, limitando la capacità della stampa di svolgere il proprio ruolo di controllo sulla democrazia.
Un altro aspetto inquietante è rappresentato dalle minacce e dalle intimidazioni rivolte ai giornalisti. In Italia, i professionisti dell’informazione che si occupano di temi delicati, come la corruzione o la criminalità organizzata, sono frequentemente bersaglio di attacchi verbali o persino fisici. Un esempio emblematico è l’aggressione subita nel 2024 dal giornalista del quotidiano La Stampa, Andrea Joly, picchiato a Torino mentre documentava una festa organizzata da estremisti. Episodi di questo tipo non solo mettono a rischio l’incolumità dei giornalisti, ma generano un clima di paura che può privare i cittadini di informazioni cruciali.
La situazione è ulteriormente complicata dall’avvento dell’era digitale. Se da un lato Internet ha democratizzato l’accesso all’informazione, permettendo a chiunque di esprimersi e di informarsi, dall’altro ha amplificato fenomeni come la diffusione di notizie false. Le cosiddette fake news minano la credibilità della stampa tradizionale e disorientano l’opinione pubblica. Questo contesto impone ai giornalisti di operare con un rigore ancora maggiore, che però non è supportato da interventi legislativi e culturali appropriati per proteggere la qualità dell’informazione e la sicurezza dei professionisti del settore.
Il declino della libertà di stampa in Italia deve essere letto come un sintomo di una democrazia che rischia di indebolirsi. Senza una stampa libera, i cittadini sono privati di uno strumento fondamentale per comprendere e partecipare alla vita pubblica. Per invertire questa tendenza, è necessario adottare misure urgenti: promuovere la lotta contro le fake news, rafforzare le leggi contro le intimidazioni e garantire un ambiente sicuro per chi svolge il mestiere del giornalista. Allo stesso tempo, è fondamentale promuovere un’educazione al pensiero critico, che permetta ai cittadini di valutare le informazioni con consapevolezza, riducendo l’impatto della disinformazione.
La libertà di stampa, oltre a essere il fondamento di una democrazia sana, rappresenta una conquista ottenuta grazie al coraggio di chi, nel passato, ha lottato per ottenerla. Difenderla oggi non significa soltanto garantire un diritto ai cittadini, ma anche onorare la memoria di chi ha sacrificato tutto per permetterci di vivere in una società libera. Per questo, non può essere data per scontata: va difesa, rafforzata e alimentata ogni giorno. Il declino registrato negli ultimi anni deve essere un campanello d’allarme per tutti, un invito a riflettere e a intervenire per proteggere questo diritto fondamentale.
Jacopo Gaibani, 2° classificato
La vicenda di Julian Assange ruota attorno alla controversa decisione di estradarlo negli Stati Uniti, dove rischia pesanti accuse per la pubblicazione di documenti riservati. Il caso solleva questioni fondamentali sui limiti della libertà di stampa e il diritto alla trasparenza, mettendo in discussione il ruolo del giornalismo investigativo di fronte agli abusi di potere. Assange ha rivelato crimini e abusi compiuti da diversi governi, in particolare quello statunitense, attraverso una vasta mole di documenti, tra cui i “war logs” su Iraq e Afghanistan. Questo ha portato a un’accusa di violazione del Espionage Act da parte degli Stati Uniti. Assange è descritto come un simbolo della lotta per la libertà di informazione e accusato di essere un pericoloso hacker. Il suo caso potrebbe dunque creare un precedente per intimidire il giornalismo investigativo e reprimere la divulgazione di notizie scomode. La persecuzione di Assange è percepita dall’opinione pubblica come un attacco diretto alla libertà di stampa e alla democrazia. A mio parere, il caso è solo la più recente ed emblematica conferma di un problema già noto. Ritengo che criminalizzare Assange equivalga ad inviare un messaggio chiaro: chi sfida i potenti e cerca di rendere conto dei loro abusi rischia la propria libertà. Questo crea un effetto deterrente per i giornalisti di tutto il mondo, dissuadendoli dal trattare temi delicati o affrontare i poteri forti. Un tale scenario danneggia irreparabilmente la democrazia, che si nutre di un’informazione libera e accessibile. Per quanto sia giusto bilanciare la sicurezza nazionale con il diritto all’informazione, il caso Assange mostra una tendenza verso un uso sproporzionato del potere repressivo, che soffoca il dissenso e la critica. La democrazia si regge su pilastri fondamentali come la libertà di espressione, la trasparenza e il diritto dei cittadini a un’informazione completa e indipendente. È attraverso un’informazione libera che i cittadini possono comprendere, giudicare e, se necessario, opporsi ai poteri che governano. Ogni volta che la stampa viene intimidita o censurata, non si attacca solo il diritto di sapere, ma si colpisce il cuore stesso della democrazia, rendendola sempre di più una illusione. Il caso Assange grida all’allarme: non è il destino di un solo uomo a essere in gioco, ma la capacità stessa delle democrazie moderne di restare fedeli ai propri principi. Difendere la libertà di chi denuncia gli abusi di potere non è un gesto simbolico, è un dovere imprescindibile per proteggere il futuro di una società libera, consapevole e giusta. Se questi principi fondamentali vengono violati, il rischio più grande è la normalizzazione dell’abuso di potere. Senza una stampa libera e protetta, i governi e le istituzioni possono agire senza timore di essere scoperti o denunciati, alimentando corruzione, ingiustizia e autoritarismo. Mentre i cittadini, privati di un’informazione autentica e indipendente, perdono la possibilità di comprendere la realtà in cui vivono e, con essa, il loro potere di partecipare e opporsi. Per cui la democrazia viene trasformata in una facciata vuota priva di un reale significato. Una stampa imbavagliata non è solo un sintomo, ma spesso un segnale d’allarme: l’anticamera di un regime autoritario, dove il silenzio diventa complice del potere, il dissenso viene soffocato e la libertà dei cittadini sacrificata in nome del controllo e dell’impunità. Il processo contro Julian Assange deve essere visto per ciò che è: una battaglia simbolica che definisce i limiti della libertà di stampa nell’era contemporanea. Proteggere il diritto di Assange di rivelare verità scomode significa proteggere il diritto di tutti i cittadini a essere informati. Nel contesto attuale, caratterizzato da un crescente autoritarismo e dalla manipolazione delle informazioni, la libertà di stampa non deve essere sacrificata sull’altare della sicurezza. Al contrario, deve essere difesa con forza, perché è il baluardo ultimo contro l’abuso di potere e il segreto di Stato.
Andrea Brizzi, 3° classificato
La libertà d’opinione è il primo ed il più importante diritto che l’uomo, una volta che si è imposto di vivere in comunità, deve porre per sé ed i suoi simili.
Questa è alla base di tutte le altre libertà, questa è la sola tutela di ogni altro diritto, eppure la sua storia è una molto lunga, fatta di uomini e donne coraggiosi, pronti al martirio. Personaggi come Socrate, Ipazia e Galileo, che ancora oggi ci ispirano: tutti costoro hanno difeso ciò in cui credevano, le proprie idee, che si trattasse della filosofia o della scienza, in una società in cui non potevano e ne hanno pagato il prezzo. La scure dell’oscurantismo e della censura, qualunque fosse la mano a reggerla, ha mandato a morte anche innumerevoli uomini e donne anonimi.
Due sono state le svolte verso la realizzazione di questa libertà: l’invenzione della stampa e la filosofia illuminista.
La stampa ha reso molto più veloce e difficile da controllare la circolazione delle idee. Basti pensare alla riforma attuata da Martin Lutero, a come la sua voce si sia propagata in tutto il nord Europa. Roma intervenne rapidamente per stroncare l’eresia che nasceva a Wittenberg, ma non ci riuscì. E non ci riuscì non tanto per la forza dei rivoltosi, ma per la velocità con cui si diffondeva la dottrina luterana. La Chiesa aveva già dovuto affrontare (e aveva sconfitto) movimenti ereticali fin dalla sua nascita, che si trattasse di Ario, Nestorio o i catari, ma non potè piegare i protestanti a causa di una macchina apparentemente insignificante: la stampante a caratteri mobili. Ogni settimana venivano stampate troppe Bibbie in tedesco, troppe copie delle novantacinque tesi perché il clero potesse metterci le sue mani ingioiellate e bruciarle. La scrittura si trovava così svincolata dalla lentezza del copista, e insieme alle lettere trovavano vigore le idee.
Ma il clima nel XVI e XVII secolo era ancora troppo cupo per permettere il pieno sfruttamento di questa prodigiosa macchina, e solo gli intellettuali, chiusi in un mondo astratto e assolutamente lontano dalla critica socio-politica, potevano usufruire degli scritti.
A portare la luce e cacciare queste cupe tenebre venne un lume, quello accesosi tra gli schiamazzi dei salotti di Parigi. L’uomo si apprestava ad uscire dal suo stato di minorità, ma sarebbe stato un processo complicato. Sarebbe tedioso per il lettore riportare in questo breve scritto tutto il processo intellettuale dell’illuminismo e politico della rivoluzione, quindi soffermiamoci su un nuovo strumento, figlio di questo processo: il giornale. Nel XVII secolo nascevano i primi giornali, dal Caffè dei fratelli Verri, dalle tematiche varie, a quelli locali, citiamo la Gazzetta di Mantova e la Gazzetta di Parma. Famoso il giornale di Jean-Paul Marat, l’Ami du Peuple, chiaro esempio del potere politico della parola. Il suo comunque non era l’unico, anzi, era uno dei tanti quotidiani e settimanali politici che venivano stampati nella Francia rivoluzionaria.
Lungi dall’essere solo stracci di carta con stampati sopra fatti di cronaca, questi giornali erano il mezzo con cui molti intellettuali facevano politica, rendendo noti le proprie idee, i propri progetti e molto spesso le proprie preoccupazioni a chi poteva leggere.
Qui nacque la questione della libertà di stampa.
I governi rivoluzionari andavano e venivano ed essi, in un periodo di guerre ideologiche e ristrettezza economica, erano molto autoritari, per quanto fossero nobili i loro ideali. Mentre la corona veniva trascinata nel fango e la Loira si colorava di rosso, venivano repressi anche molti dei giornali che all’inizio avevano sostenuto la rivoluzione.
Prima vennero colpiti i controrivoluzionari e i rivoluzionari moderati, di cui Marat chiedeva esplicitamente la testa in quasi ogni numero del suo Ami du Peuple; poi lo stesso Marat, la cui penna era davvero più potente della spada, pugnalato a morte nella sua vasca ed immortalato per sempre da David.
Con Napoleone si cercò di limitare la libertà di stampa, e così con la Restaurazione e in molti regimi del Novecento; ma nessun governo, per quanto autoritario ed illiberale, riuscì mai a fermare la stampa e giornali d’opposizione, spesso distribuiti segretamente, erano sempre in circolazione.
E con questo si arriva al giorno d’oggi. In Occidente lo stato moderno, che forse è riuscito ad imparare qualcosa dalla storia, si sforza, talvolta con fatica, di garantire questa libertà. I giornali oggi possono anche essere telegiornali o digitali, ma rimangono pur sempre lo strumento (e l’arma) formidabile che sono sempre stati, anzi, toccano un pubblico ampio e sempre più diverso.
Come accennato all’inizio, la libertà d’opinione, che include ed è imprescindibile dalla libertà di stampa, è il primo dei diritti di una comunità civile e quello su cui si reggono tutti gli altri. La libertà di poter dire la propria è la panacea a tutte le possibili degenerazioni del sistema democratco-liberale.
La storia, nel suo scorrere perpetuo ed irresistibile, porta necessariamente con sé dei mutamenti e i mutamenti causano squilibri nella società. Il mondo è fatto per andare avanti, che si tratti di progresso tecnologico o culturale, e l’uomo avanza, anzi, è strattonato assieme a tutto ciò che ha creato; eppure lui in tutto questo rimane tale e gli serve tempo per adeguarsi ai cambiamenti.
Qui interviene questa libertà: la stampa offre la possibilità di diffondere una visone, un’interpretazione di un cambiamento o perfino delle soluzioni ai nuovi problemi e di andare avanti, invece che voler rimanere indietro e rifiutare a priori il futuro. La scrittura è, e sempre sarà il nostro riparo davanti al tempo. Un chiaro esempio di ciò lo possiamo vedere nella rivoluzione industriale.
Partendo da una situazione di assoluto liberismo, i lavoratori della neonata società industriale, fino a poco prima contadini, erano costretti a condizioni umilianti e salari da fame; in molte parti del mondo è ancora così. Oltre che di fumo e sporcizia, le strade di Londra si riempivano di lamenti, quelli della nuova classe operaia. E questi lamenti, per tutti gli altri silenziosi, furono amplificati dalla carta e portati alle orecchie del governo; e quando questi non ascoltarono, la carta, che non poteva più essere censurata come nei secoli precedenti, non smise di fare pressione. Si arrivò così ad una serie di riforme e le condizioni dei più umili migliorarono: la società, coadiuvata dalla stampa, prese la decisione di andare avanti nonostante l’opposizione di una parte consistente di essa. I diritti si sono adeguati al tempo, e questo grazie a quella prima libertà fondamentale.
Un’altra degenerazione della società umana, questa dovuta agli uomini e non al progresso, è l’indifferenza, una malattia che porta all’appassire di tutti i diritti e tutte le libertà conquistate con il sudore e il sangue.
Se essere indifferenti nella vita personale è facile e talvolta conveniente, lo è ancor di più in quella pubblica; ma così ci si impoverisce moralmente, si perdono amici, opportunità e, nel caso della società, si è in balia della propaganda. La stampa e l’informazione sono i pungoli della vita civile, le cui sferzate costringono all’attenzione. Una corretta informazione, libera e capace di esprimere pareri anche contrastanti, smuove il pubblico e lo costringe ad abbandonare l’indifferenza invece che il suo futuro.
Non serve scavare lontano nella storia per trovare buoni esempi dell’informazione come “pungolo” di una società democratica impigrita dall’indifferenza. Basti pensare a Julian Assange e al suo progetto, Wikileaks. L’opinione pubblica americana, dopo un evento traumatico come gli attentati dell’undici settembre, non si è mai realmente opposta agli interventi militari dello studio ovale, vedendoli spesso come una giusta risposta. Assange ha ribadito, tramite i documenti trafugati dal Pentagono, che “guerra giusta” è solamente un ossimoro, espressione più adatta alla retorica che ad una discussione seria. Dietro all’esportazione della democrazia ci sono degli interessi, e la strada per questi è spesso cosparsa dei corpi di non-combattenti. Lo zio Sam, il benevolo giudice, giuria e boia del mondo, è un criminale di guerra. Julian Assange è stato incarcerato, ma, come la storia dimostra, non puoi fermare la stampa o, in questo caso, internet. Ed ecco che i documenti pubblicati dal giornalista appaiono per la prima volta davanti agli occhi di un pubblico che al meglio era indifferente davanti alla guerra in Iraq; l’informazione ha scatenato un putiferio e ha coperto di imbarazzo la Casa Bianca. Le discussioni suscitate da queste pagine vanno avanti ancora oggi, con Assange che è stato liberato di recente.
Dopo aver citato questa figura, risulta spontanea la prossima domanda: come facciamo a riconoscere se la libertà d’opinione, la libertà di stampa sono in pericolo?
La dialettica. Qualora venga a mancare la dialettica, allora la libertà è in pericolo.
Il caso Assange ha suscitato immense polemiche e critiche da e verso qualsiasi parte, ma se ne è parlato. Eccome se se ne è parlato, e con pareri discordanti; e questo è il più grande segnale di una società democratica e sana, il non essere d’accordo e dirlo, in maniera costante. Nel disordine della pluralità troviamo la prova della nostra libertà. E queste polemiche hanno tenuto vivo il problema, fino alla liberazione di Assange.
Dunque: l’informazione come mezzo di espressione intellettuale e visione della società e l’informazione come antidoto all’indifferenza, la dialettica come segno di una informazione davvero libera. Ma il “come” di questa libera informazione?
Citiamo il ventunesimo articolo della nostra costituzione: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con le parole, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure”. I padri costituenti furono molto lungimiranti in questo, “le parole lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione”.
Oggi la libertà di stampa non si estende solo alla “stampa” cartacea, ma ad un mondo di media molto più numerosi e complicati, che rendono più facili manipolazioni e polarizzazione. Eppure questo diritto rimane lo stesso e deve rimanere lo stesso, qualunque sia il mezzo, dalla carta allo schermo.
La disinformazione, le fake news, per usare una formula più moderna, sono un male necessario, conseguenza naturale di questa libertà inalienabile. La censura, anche se volta alla tutela del vero, è pur sempre censura, e una restrizione apre necessariamente la strada all’imposizione di altri limiti. A combattere la “cattiva informazione” può esserci solo la “buona informazione”, la dialettica citata prima, non la mano di un censore; e questa non deve porre veti nemmeno su quei contenuti “dannosi” per la democrazia, è questo per due motivi: è un fine nobile ma facilmente manipolabile, con pareri semplicemente non condivisi che diventano demoni, e il suo uso impigrisce la democrazia che si propone di proteggere, abbassando ad un dogma piuttosto che un qualcosa di tutti e in cui tutti possono dire tutto, anche cose sbagliate, suscitando così discussioni e confronti costanti.
Concludendo, io non penso che in occidente la libertà di stampa sia in pericolo, anche se alcuni episodi, primo tra tutti quello di Julian Assange, fanno riflettere molto su essa, la sua storia e la sua importanza; ma non è così in gran parte del mondo, dove sono impressi sulla carta non visioni e legittime critiche ma dettami. Noi possiamo (e dobbiamo) prenderci il tempo di riflettere e alzare lo sguardo dal nostro giardino a quello del vicino, ed avere la forza di provare compassione per lui.
Solo quando alzeremo lo sguardo agli altri allora la libertà di stampa potrà essere totale, solo allora la libertà d’opinione, la prima e la più sacra, sarà trattata con il giusto rispetto, consentendo così all’uomo di tutelarsi in una società veramente democratica e resa stabile dal costante scambio di pareri, progetti ed idee.
Condividi questo contenuto
GLI ULTIMI ARTICOLI DI EUREKA: